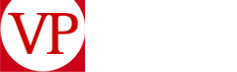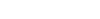Tra crimine e morale. L’esperimento di Victor Frankenstein e le tentazioni anarchiche di Mrs Shelley
Daniele Velo Dalbrenta
Professore associato di Filosofia del diritto, Università di Verona
Tra crimine e morale.
L’esperimento di Victor Frankenstein e le tentazioni anarchiche di Mrs Shelley***
Between Crime and Morals.
The Experiment of Victor Frankenstein and the Anarchist
Temptations of Mrs Shelley
Era il tempo migliore, era il tempo peggiore, era l’età della saggezza, era l’età della stupidità, era l’epoca della fede, era l’epoca dell’incredulità, era la stagione della Luce, era la stagione delle Tenebre, era la primavera della speranza, era l’inverno della disperazione, avevamo tutto dinanzi a noi, non avevamo nulla dinanzi a noi, eravamo tutti diretti al cielo, eravamo tutti diretti dall’altra parte.
C. Dickens [1]
Sommario: 1. La vertigine dell’assoluto. – 2. Per una società diversa. – 3. Tra crimine e morale. – 3.1. Il ‘corpo’ del delitto. – 3.2. La giustizia non è di questo mondo. – 4. Conclusivamente (ulteriori dubbi).
1. La vertigine dell’assoluto.
Per singolare che possa parere, nel rileggere Frankenstein ci si sofferma di solito sul sottotitolo[2], da cui si evince il suo carattere di ‘mito’ moderno della creazione (per dirla con una sorta di ossimoro); un ‘mito’ che si scosta sensibilmente da ambo le tradizioni costitutive della civiltà occidentale: novello Prometeo, Victor Frankenstein si adopera infatti per (ri)creare la vita ‘in proprio’, recidendone così ogni legame col divino[3].
In effetti, se nel mito propriamente detto Prometeo viene incaricato da Zeus di plasmare l’Uomo, insufflandogli la vita, mentre nell’Antico Testamento la Creazione di Adamo costituisce opera integralmente divina, con Frankenstein troviamo una ‘creazione’ moderna perché rimessa per intero nelle mani dell’uomo, che ha ormai strappato alla natura il segreto della vita (cosa che – giust’appunto – atterrisce)[4].
Nessuna meraviglia, perciò, che Frankenstein stesso si autocomprenda, e racconti, come simbolo dell’umana hybris, vale a dire, di quella sete di conoscenza che, portata all’estremo, si rivela mortifera: come è ‘accaduto’ dalla mela di Adamo in giù, passando certamente per il furto del fuoco ad opera dello stesso Prometeo, che aveva inteso beneficiarne il genere umano, altrimenti troppo vulnerabile[5].
Quanto poi il dono recato dal Titano – con l’inganno – sia stato di giovamento agli uomini, pur così riscattati dallo stato ferino nel quale erano stati precipitati dalla divinità, può costituire fonte di dubbio, specie con riferimento ai conseguenti sviluppi della tecnica e della scienza[6]. Non per niente uno degli attributi di Prometeo, ‘portatore di fuoco’ (Pyrphoros), ci riporta direttamente – possiamo dirlo? – a Lucifero.
E Victor Frankenstein? A differenza di Prometeo (‘colui che sa prima’), e al pari del di questi fratello Epimeteo (‘colui che apprende solo dopo’), la cui vicenda si lega al vaso di Pandora, egli assaggerà il frutto proibito, ignaro che si troverà così costretto ad assistere alla morte dei propri affetti (familiari ed amici), per lanciarsi all’inseguimento della sua ‘creatura’ e spegnersi infine in un remoto e desolato lembo di mondo, perso tra i ghiacci, consumato da un odio inestinguibile e in completa solitudine (o quasi).
Del mito Frankenstein ha, senza dubbio, il carattere immemorabile, nonostante la dichiarata modernità. O forse proprio per questa: in un’età in cui l’uomo era rimasto solo, avendo ormai sostituito le ideologie a quei miti che ‘riempivano’ il mondo, era necessario trovare una figura che esprimesse paradigmaticamente, con il suo doloroso destino, come il connubio tra tecnica e scienza[7], per non divenire ideologia suprema, e creare ‘mostri’, fosse chiamato ad acuire la consapevolezza dei limiti della condizione umana[8].
Sullo sfondo dell’operazione ‘mitopoietica’ attuata da Mary Shelley, le ragioni del progresso tecno-scientifico si saldano allora con quelle della riguadagnata libertà umana, di cui esso dovrebbe costituire espressione prima, a patto che ciò non comporti il sacrificio di quel che il più comprensivo ordine naturale sembra imporci come necessario: di qui appunto il giudizio inappellabilmente negativo sull’esperimento di Frankenstein (di qui gli stessi usi dispregiativi del suo nome, assurto a metafora di bruttura).
Il titanismo romantico di Victor Frankenstein esprime pertanto una nuova vertigine di assoluto, ma l’esito si direbbe palesemente catastrofico, e l’unica liberazione resta per lui quella dalla vita[9]. Tra l’altro, a liberarlo sarà, con una curiosa inversione, lo stesso ‘essere’ da lui creato, che si presenta dunque come un novello Eracle, la cui forza sovrumana non è però più frutto di un’ascendenza divina, ma dell’uomo stesso (si ricorderà certo che nel mito fu il semidio Eracle a liberare Prometeo dalla rupe, facendone cessare il supplizio).
Non vorrei peraltro impastoiarmi negli accostamenti mitologici, e nei relativi rimandi simbolici[10]. Se non altro perché, anche trascurando il carattere moderno, e dunque fondamentalmente individualistico del romanzo,si tratta comunque di un terreno piuttosto sdrucciolevole, attesa la complessità della mitologia (non foss’altro che per via delle innumerevoli versioni esistenti di ciascun mito). E sembra d’altronde ragionevole supporre che il riferimento a Prometeo importasse solo nella sua genericità (avendo questi creato l’uomo)[11].
D’altronde, non vorrei qui neppure sbilanciarmi sull’incidenza dell’aspetto ante litteram bioetico di Frankenstein[12]: nonostante trapeli consapevolezza, da parte di Mary Shelley, circa gli elementi di novità presenti in un intreccio in cui la realtà stempera nell’immaginazione per sollecitare la riflessione critica sulle implicazioni etiche delle conquiste tecnico-scientifiche (moderne), tale consapevolezza non sembra completamente disgiungibile da una qualche preoccupazione di inserirsi nel pubblico dibattito[13].
Allo stesso modo, per finire, trascurerei la lettura ‘gotica’ dell’opera che, mettendone in ombra la vastità di riferimenti, vorrebbe farne un feticcio romantico, nato dalla tenebrosa ispirazione intervenuta in quella fredda e piovosa settimana del giugno 1816, a Villa Diodati, sul lago di Ginevra, in un certamen letterario che avrebbe visto coinvolti anche il marito, Byron e Polidori (lettura forse alimentata ad arte, nel tempo, dalla stessa autrice – si confrontino la prefazione del 1818, da ascrivere peraltro a Percy, e quella del 1831)[14].
Scartate le predette chiavi di lettura (mitico-simbolica, pre-bioetica e romantica), peraltro diffusissime, potrebbe invece riuscire interessante ripercorrere le linee fondamentali di Frankenstein in termini genealogici, muovendo cioè da quegli aneliti di emancipazione, personale e sociale che ne travagliarono l’autrice, e che sembrano ricollegabili all’ingombrante figura paterna e alla tangibile assenza materna non meno che al cólto radicalismo del marito.
Lungi ovviamente da me il proposito di spacciare per originale l’approccio ‘biografico’[15], ché anzi è forse esso a costituire la cifra comune degli studi su Frankenstein, potendo dar meglio conto del disincanto dell’opera e ancor più della forza del negativo che da essa si sprigiona – la quale trova immediata rispondenza nel ruolo passivo, (a tutta prima) secondario. che vi riveste il femminile, al limite inutile (se l’esperimento fosse andato a buon fine)[16].
Molto più semplicemente preme qui sottolineare come un’attenta considerazione della personalità e dei legami familiari di Mary Shelley conduca a riconoscere la centralità, nel disegno dell'opera, delle stesse tematiche di rilevanza giuridica, e in particolar modo di quelle attinenti alla giustizia penale e al ruolo da essa svolto nella vita sociale (anziché limitarsi a rubricarle come aneddotica intesa a calcare la crudeltà, e l’impunità, del ‘mostro’).
2. Per una società diversa.
È un po’ il segreto di Pulcinella: Mary Shelley da nubile faceva Godwin, in quanto figlia di quel Godwin. Quel Godwin che, fidando nell’universalità della ragione, predicava una società senza coercizione, e perciò senza politica e diritto. Quel Godwin il cui radicalismo ‘senza sconti’ fece sì che in lui Lev Tolstoj e Pëtr A. Kropotkin riconoscessero il primo teorico dell’anarchismo[17].
Ma è egualmente noto che Mary portava altresì il cognome materno Wollstonecraft proprio perché figlia di quella Wollstonecraft, che peraltro ella – in definitiva – non ebbe quasi modo di conoscere, essendo morta pochi giorni dopo averla data alla luce. Quella Wollstonecraft che si batté per la dignità della donna (espressione forse tradita dal termine ‘femminismo’), con i suoi ineludibili diritti[18].
Se poi aggiungiamo che Mary è parimenti conosciuta, fin dal cognome ‘principale’, per essere stata moglie di quel Shelley, poeta aristocratico e insofferente alle regole, precocemente strappatole da una tempesta al largo di Lerici, il quale pure si riconosceva pienamente nel ‘credo’ anarchico [19], e perciò aveva grandemente ammirato lo stesso William Godwin, il quadro familiare può dirsi completo.
Certo, v’è subito da aggiungere che l’indole anarchica che contraddistingueva i familiari di Mary doveva spesso scendere pesantemente a patti con la realtà.
Godwin disprezzò e sfidò le convenzioni sociali, ma poi, per amore della fidanzata incinta, s’indusse a sposarla. In ultimo, per la penuria di mezzi di sostentamento, cedette ai sussidi di Stato. D’altronde, la stessa unione di Mary, nata – al pari di quella dei genitori – all’insegna dello scandalo (essendo Shelley già sposato con una figlia), era destinata ad imborghesirsi nel matrimonio (per quanto tormentato e sotto diversi aspetti anomalo), ed i rapporti parentali ad incrinarsi ulteriormente: per dire, l’ammirazione che il marito nutriva per suo padre si sarebbe presto infranta nelle difficoltà economiche di quest’ultimo (che si sostanziavano in continue richieste di somme di danaro, peraltro accompagnate da strane manifestazioni di risentimento – non si sa bene se dovute all’indebita ‘seduzione’, ad una malcelata gelosia o ad una qualche forma di invidia).
Riverberi di tale attitudine anarchica ‘di famiglia’ vengono razionalmente mediati da Mary Shelley, in cui potevano comunque dirsi a tutta prima meno evidenti, anche per via della difficoltà di convivere con la sofferenza che avevano in lei generato il senso di colpa per la morte della madre, la delusione del padre per la nascita di una figlia, le seconde nozze di questi, il raffreddarsi dei loro rapporti[20].
Nondimeno, complice forse quella sensibilità peculiare che accomunava tutti i componenti della famiglia e si esprimeva nelle lettere, un’attitudine di ribellione verrà presto riemergendo in Mary sulla pagina scritta: affidata alla sua corrispondenza privata, ma in special modo, come verremo appunto sostenendo, alla sua opera prima, in cui ella canalizzò le sofferenze di una famiglia che, di fatto, non c’era più[21].
E, in effetti, una certa vena ‘anarcoide’, del resto particolarmente viva in Mary Shelley negli anni giovanili (la stessa che la porterà tra le braccia di Percy), può senz’altro dirsi percorrere proprio quella sorta di fiaba ‘nera’ che è Frankenstein, consegnato alle stampe quando ella era appena diciannovenne, ed uscito poco prima del fatidico viaggio in Italia con il marito e i figli (che presto moriranno)[22].
Il successo, cui l’opera sarebbe andata incontro solo progressivamente[23], sarà anzitutto metaforico, come attestano numerosi ‘svarioni’ divenuti nel tempo – inestirpabili? – luoghi comuni (come la confusione tra il nome del ‘creatore’ e quello – inesistente – della ‘creatura’, la supposta brutalità congenita a quest’ultima, che invece sviluppa – nel romanzo – grandi doti culturali e logico-argomentative, la stessa prestanza fisica della medesima, sovente immaginata come goffa e lenta, a dispetto dell’incredibile agilità descritta dall’autrice). Luoghi comuni generalmente incompatibili con un accesso diretto all’opera, perlomeno nella sua versione originale (che, anche ad una rilettura, può riservare molte sorprese)[24].
Nella prospettiva Law & Literature, in cui si colloca il presente contributo, le pulsioni anarcoidi della ‘mite’ Mary – provata in più circostanze da duri colpi del destino (oltre a quanto sopra richiamato, si considerino almeno la morte di un altro figlio in tenera età, nonché gli incalzanti problemi finanziari, che l’assilleranno per buona parte della sua vita) – si possono cogliere nell’invocare, fin da giovane, una società più ‘giusta’ di quella che il diritto pretenderebbe di garantire. È così che, sottotraccia, discopriamo in Frankenstein la questione che costituisce il «Capo Horn» della riflessione critica sul diritto (per usare un’espressione di Jhering ripresa maliziosamente da Croce)[25], e cioè il rapporto tra diritto e morale.
Nello specifico cercherò di evidenziare come Mary Shelley, lungi dal vedere riconciliate – nel vivere sociale – le ragioni del diritto con quelle della morale, assuma, consapevolmente, una posizione assai ambigua, esemplarmente rappresentata dall’offuscata immagine che Frankenstein offre di ciò che costituisce – la massima espressione della violazione del diritto, ossia il – crimine[26].
3. Tra crimine e morale.
La ‘creatura’ è sì ripugnante, ma, a ben leggere, di una ripugnanza che ha più della sproporzione, della spettralità, della innaturalità della complessione[27] – al di là delle fattezze isolatamente considerate, che pure Victor Frankenstein aveva selezionato come ‘belle’[28].
Sicché nella prima immagine ufficiale, costituita da un’incisione di Theodore von Holst, sul frontespizio dell’edizione del 1831, a colpire è soprattutto la statura gigantesca: quasi a suggerire che la sua ‘deformità’ rappresenta solo un riflesso morale nella mente del ‘creatore’[29].
Successivamente, però, questa incertezza nel tratteggiare la ripugnanza della ‘creatura’ comincia a sfumare, mentre l’iconografia della stessa viene progressivamente definendosi, e facendosi prossima al caricaturale: ciò accade poco a poco, con diverse oscillazioni, talora vistose.
Infine, grazie anche ad alcuni adattamenti teatrali, l’iconografia della ‘creatura’ viene cristallizzandosi nei caratteri resi celebri da Boris Karloff, i cui tratti somatici – camuffati e resi abnormi dalle sapienti mani di Jack Pierce – la impersonano nella storica trasposizione cinematografica di Whale (1931).
E ciò accade, come ben testimonia anche la preparazione del casting di tale pellicola[30], attraverso un’iconografia – per dir così – posticcia, che risente da vicino della teoria antropologico-criminale di Cesare Lombroso, peraltro lungi dall’apparire all’epoca in cui venne dato alle stampe il romanzo.
Potrà allora tenersi per sensata un’ipotesi di lavoro secondo cui, correlativamente al mutare dell’iconografia, e anzi in ragione di ciò, quanto venuto dopo la pubblicazione di Frankenstein può aver distorto una seria riflessione critica su ciò che in esso può dirsi propriamente ‘criminale’.
3.1. Il ‘corpo’ del delitto.
Com’è noto, per Lombroso «[i]l delitto … appare, così dalla statistica come dall’esame antropologico, un fenomeno naturale, un fenomeno, direbbero alcuni filosofi, necessario, come la nascita, la morte, i concepimenti … ». Egli ravvisa, cioè, una sorta di necessità naturale nel delitto, che lo stringerebbe a leggi generali, sostenendo in particolare di aver riscontrato in natura, quale variante antropologica, una costituzione delinquenziale: la costituzione atavistica, e cioè retrograda rispetto al grado di evoluzione raggiunto dalla specie. Il delinquente, in senso costituzionale, altri non sarebbe che un individuo umano incline a riprodurre comportamenti propri dell’umanità dei primordi, mostrando un’invincibile inclinazione a commettere quello che la società moderna reputa invece ‘criominale’[31].
Tale essere atavistico si sarebbe pertanto potuto descrivere scientificamente, a cominciare dai tratti somatici: talmente grossolani ed aberranti da portarci immediatamente davanti agli occhi … la ‘creatura’ di Victor Frankenstein. Ma, appunto, solo se considerata nell’iconografia ‘contraffatta’ – e derivata – di cui sopra.
Sennonché, Mary Shelley non fu certo un Lombroso in gonnella, e le suggestioni proto-lombrosiane che parrebbero ricorrere in Frankenstein sono semmai dovute alla conoscenza di testi scientifici all’epoca piuttosto diffusi, riconducibili ad autori indubbiamente considerati antesignani di Lombroso. Si possono fare i nomi di Gall, che – con la sua frenologia – si provò a legare le facoltà umane alla struttura anatomica, concentrandosi sul cranio e le – pretese – localizzazioni cerebrali (rispolverate, perlomeno nelle intuizioni, dalle contemporanee neuroscienze), e soprattutto di Lavater (1741-1801), svizzero (e quindi concittadino di Frankenstein!), cui si dovevano importanti studi di fisognomica, la ‘scienza’ intesa a ricavare i caratteri dai tratti somatici[32].
Naturalmente è molto difficile dire cosa vi possa essere di ‘scientifico’ in tutto questo, dato che solo una irraggiungibile conoscenza assoluta – prerogativa di una mente divina – consentirebbe di statuire cosa sia davvero ‘scienza’, e quindi di determinare con certezza cosa resterà scientifico nel corso del tempo[33].
Tuttavia è pur vero che, parlando dell’aspetto ominoso di qualcheduno, le nostre ricerche potrebbero risalire dalla modernità giù giù fino al mondo antico, che già pullula di teorie che suggeriscono una corrispondenza ‘scientificamente’ controllabile tra facies externa (corporeità) e facies interna (interiorità)[34].
Sia come sia, però, la mostruosità descritta da Mary Shelley nella ‘creatura’, i cui tratti somatici non appaiono invero ben definiti, è qualcosa che assume connotazioni metafisiche: Walton osserva che v’è alcunché di «spaventoso» (scaring) e «ultraterreno» (unearthly) nella sua «bruttezza» (ugliness)[35].
In realtà, man mano che procede la narrazione s’insinua nel lettore l’oscuro convincimento che la ripugnanza ingenerata dalla vista della ‘creatura’ abbia a che fare, più che con la fisionomia della stessa, con la condotta di Frankenstein, il quale, dopo averla ‘ricavata’ da materia disanimata, l’abbandona, lasciandola ad attraversare – prostrata – il mondo in uno stato di reale indeterminatezza: sospesa cioè tra vita e morte, umanità ed inumanità, crimine e morale.
A tale ultimo riguardo, si noterà in particolare come la ‘creatura’ si spinga al ‘crimine’ – e si senta anzi legittimata a compierlo – proprio nella ricerca di quel riconoscimento morale negatogli dal suo stesso creatore, che, a sua volta, si sente moralmente gravato di tutte le conseguenze della sua ‘creazione’.
Alla radice della vicenda viene insomma in evidenza il concetto di responsabilità, concetto al tempo stesso morale e giuridico: riconoscere la responsabilità per un evento lesivo sta invero a significare che si ‘tramuta’ il medesimo – da fatto naturale – in esito di una condotta contraria alla morale e/o al diritto.
Ora, si può essere considerati – in astratto – ‘responsabili’ per il ruolo che si riveste, perché si è causa di qualcosa, in forza di principi e regole del diritto, oppure semplicemente per via della propria capacità[36]. Nondimeno, proprio la vicenda di Frankenstein e della sua irresponsabile (?) ‘creazione’ indurrebbe a ritenere che si debba (ri)partire sempre dall’accezione causale come accezione centrale.
Questo perché, dinanzi ad un qualsiasi evento lesivo che si determini nell’esperienza, tutte le possibili accezioni di ‘responsabilità’ paiono anzitutto convergere verso il riconsiderare se un dato individuo ha costituito o meno, con la sua condotta, causa dell’evento lesivo in discorso.
Tuttavia è parimenti vero che se dovessimo ogni volta risalire di causa in causa per attribuire la responsabilità di un determinato evento lesivo, rischieremmo di approdare a conclusioni insensate, finendo con il formulare giudizi anche sulla base di fatti accidentali (come per esempio l’aver determinato un ritardo rivelatosi poi – per altri – fatale).
Torniamo così a quanto lambito sopra (trattando di cosa sia ‘scienza’): l’essere umano è in effetti fallibile, e solo una mente onnisciente sarebbe in grado di ricollegare causalmente lo stato presente dell’universo a quello anteriore e a quello successivo, di modo che l’avvenire come il passato sia sempre presente ai suoi occhi: formulando previsioni ‘perfette’ per il futuro, e attribuendo responsabilità ‘perfette’ per il passato[37].
Ciò precisato, quand’è che risulta allora non arbitrario, per l’uomo, arrestarsi nel risalire la catena delle cause per l’attribuzione di responsabilità? E se si dovesse comunque riscontrare arbitrarietà nel fissare (e cioè stabilire) una causa tra le innumerevoli considerabili, ci si dovrebbe forse risolvere a liquidare l’idea di ‘responsabilità’? E ancora: in tale ultimo caso, potremmo forse continuare a parlare di crimini e di atti contrari alla morale?
Ebbene, le ‘risposte’ che Mary Shelley sembra offrire, con Frankenstein, consistono – a ben vedere – in una riformulazione approfondita delle suddette domande, che guadagnano così lo spessore dell’opera d’arte, per quanto acerba e ‘di diversione’[38].
In effetti, molte morti violente costellano il romanzo[39], ma chi ne è l’autentico responsabile? Non è forse la ‘creatura’ il ‘corpo del delitto’ (di Frankenstein), nella duplice accezione penalistica dell’espressione (ciò su cui o attraverso cui il delitto è stato compiuto)?
E questo forse non significa, in ultima istanza, che è lo stesso essere umano a ‘creare’ – in sé o nell’altro – il criminale? Si tratta di una tipica tesi anarchica. Ma è anche quanto parrebbe effettivamente insegnare, in chiave metaforica, la vicenda dell’esperimento di Frankenstein e delle sue inintenzionali conseguenze, dovute al corpo cui ha dato vita (?)[40]. Come dire: un’eclatante riconferma dell’umana fallibilità.
3.2. La giustizia non è di questo mondo.
Nel dialogo finale che si svolge tra Walton e la ‘creatura’ c’è un passo particolarmente rivelativo, ancorché la sua estrapolazione dal contesto non ce ne restituisca pienamente la densità: dice, ad un certo punto, la ‘creatura’, riferendosi all’ingratitudine dimostratale da molti: «Solo io devo essere ritenuto un criminale, quando tutta l’umanità peccava contro di me?»[41].
Eppure, è ancora la ‘creatura’ a riconoscerlo, le scelleratezze che ha commesso sono lì a testimoniare, con il suo cupio dissolvi, l’essersi data al crimine, e l’esserne stata anzi «corrotta» (poco prima aveva parlato di «degradazione» alla condizione animale a causa dei crimini perpetrati in preda ad una inestinguibile sete di vendetta nei confronti del genere umano).
Ecco, è precisamente nella sofferta autocomprensione che la ‘creatura’ esibisce dei propri misfatti (e non nell’iconografia posticcia), che paradossalmente, ma forse neppure troppo, troviamo una sorta di anticipazione della concezione antropologico-criminale ideata da Lombroso nella seconda metà del XIX secolo e in seguito sviluppata ad opera della Scuola Positiva italiana[42].
Al riguardo, la ‘creatura’ ci appare infatti dilacerata: essa non esita a chiamare ‘crimini’ i propri atti, pur avendo poco prima ammesso di essere schiava – meglio forse dire ‘vittima’? – di «un impulso che detestav[a], ma a cui non potev[a] disobbedire»[43].
Ora, proprio l’Antropologia criminale riterrà insensato il discorso sulla responsabilità (penale) per limitarsi a riconoscere, avvalendosi di apporti tecnico-scientifici, che vi sono individui inclini al crimine per ‘impulso’ naturale, dai quali bisogna difendere la società (riformando in senso preventivo il sistema penale)[44].
Secondo tali parametri, anche dalla ‘creatura’, pertanto, non si ci potrebbe (dovrebbe) che difendere. Se solo qualcuno si accorgesse della sua presenza… (oltre a Frankenstein, che forse anche per questo sente ricadere sulle proprie spalle la responsabilità per gli atti della medesima…).
Qui, però, Mrs Shelley spariglia: sfruttando la forza dell’immaginazione, ella rifiuta una facile spiegazione ‘naturalistica’ del crimine (in certo qual modo – in Frankenstein – scienza e tecnica ne sono alla base, anziché proporsene come rimedio), superando al tempo stesso la semplice denuncia sociale contenuta in Caleb Williams, apprezzato proto-giallo del padre[45].
Certamente in Frankenstein possiamo ritrovare più di qualcosa di Caleb Williams: ben oltre la scontata sensibilità per le tematiche socio-politiche che vi emerge, si può infatti pensare ai meccanismi narrativi, come il confronto a distanza tra i protagonisti che scandisce l’intera vicenda.
In Caleb Williams, però, Godwin sembra dedicarsi prevalentemente all’inaggirabilità delle convenzioni sociali e della stessa estrazione cetuale: la detective story, di cui forse questo romanzo detta le regole, viene così ridimensionando la critica sociale, stemperandosi in – irresolute – considerazioni sociologico-esistenziali.
Con Frankenstein ci viene invece insinuato un dubbio radicalmente ‘anarchico’: si dovrebbe per prima cosa cercare di comprendere se, dietro ciò che ci apprestiamo a chiamare ‘crimine’, non vi siano fattori di esclusione sociale (come d’altronde riterrà la direttrice sociologico-criminale del positivismo penale italiano[46]).
E tale dubbio investe il funzionamento stesso della giustizia (penale) come ‘macchina’: come espressione istituzionale (di una certa forma) del vivere associato, e dunque con rituali funzionali al consolidamento della comunità, che esigono che dei ‘colpevoli’ siano assicurati alla ‘giustizia’.
In breve, la giustizia (penale) viene qui presentata come un ingranaggio che può stritolare l’innocente in nome del bene comune: a tutto vantaggio del potere politico, la cui risposta al crimine può completamente svincolarsi dalla materialità del medesimo, purché rinsaldi il corpo sociale[47].
Quanto risuona allora lontano in queste pagine, diremmo quasi: fasullo, il monito liberale – per tradizione attribuito a Sir John Fortescue – secondo cui sarebbero preferibili dieci colpevoli in libertà piuttosto che un solo innocente condannato (monito che in effetti compare nel romanzo di Mary Shelley, ma… invertito[48]).
Si guardi al processo a Justine: non sarà certo sfuggita, nel nome, l’allusione allo sventurato personaggio del ‘Divin marchese’, emblema della persecuzione e della rovina cui infallibilmente condurrebbe la virtù. Ebbene, il ‘fulmine’ che colpirà l’omonimo personaggio di Mary Shelley sarà la ‘giustizia’[49].
Un analogo caso di processo-farsa, con dichiarate implicazioni politiche, è quello del vecchio De Lacey, che si concluderà con una sentenza manifestamente ingiusta: di talché la giustizia trionferà, se così si può dire, solo quando Felix riuscirà a farlo evadere di prigione, evitandogli la condanna capitale[50].
Infine, neppure un giudice intelligente e sensibile come Mr Kirwin sembra sulle prime capace di sottrarsi a tali logiche sociali, e Frankenstein viene indagato, pur con labili indizi, per l’omicidio di Clerval[51]. La giustizia (penale) – si fa capire in Frankenstein – deve seguire il proprio corso. Costi quel che costi.
In altre parole, ciò che gli uomini chiamano qui ‘giustizia’ sembra dissolversi in una nebulosa di ottusità e connivenze, mentre l’innocenza, che della giustizia dovrebbe farsi scudo, si mostra insidiata proprio da quegli apparati e procedure formalmente finalizzati a contrastare il crimine.
Troviamo così in Frankenstein una scoperta compassione nei confronti dei condannati, considerati persone cadute in disgrazia, che ricorda da vicino la compassione espressa dalla madre di Mary in alcune lettere scritte durante un viaggio nei paesi scandinavi (di cui si era incaricata per amore di un avventuriero americano)[52].
E troviamo, ancor più in generale, una aperta denuncia della reificazione dell’essere umano etichettato come ‘criminale’; reificazione d’altra parte presupposta nella stessa pratica scientifica dell’epoca: in ispecie in quegli esperimenti di galvanismo cui si rifà Frankenstein proprio per attingere il principio… della vita (!)[53].
Fece in particolare sensazione, all’epoca, l’esperimento condotto al Londra nel 1803 dal professor Giovanni Aldini (nipote di Luigi Galvani), sul cadavere di un uomo giustiziato per omicidio nella prigione di Newgate, George Foster, il quale sarebbe stato – in certo qual modo – ‘rianimato’ con degli elettrodi[54].
Nonostante tutto questo, però, quel che non troviamo, in Frankenstein, è una critica radicale dell’intera impalcatura istituzionale su cui si reggerebbe la società mediante procedure ed apparati che costituiscono meri marchingegni di controllo sociale deputati a trasformare la forza bruta in coercizione giuridica.
Questa rimane una tentazione, che fa capolino qua e là, inducendo a riflettere sul contesto dell’opera: un’Europa che aveva vissuto, nell’arco di un ventennio, la temperie rivoluzionaria francese, che l’aveva scossa fin dalle fondamenta, l’epopea delle guerre napoleoniche e, in ultimo, la Restaurazione.
In tal senso, lo scorcio di secolo in cui appare Frankenstein è popolato di ben altri ‘mostri’, che affiorano tra le sue pagine, e che hanno a che fare con le profonde trasformazioni cui sta andando incontro l’Occidente sotto l’egida del progresso, dopo secoli di – pur travagliato – ‘equilibrio dinamico’[55].
Trapela perciò, da queste pagine, una certa diffidenza nei confronti di ogni rivolgimento che si proponga di ristabilire, nella società, la ‘giustizia’ (e si tratta esattamente della stessa diffidenza espressa da Dickens – a partire dai fatti rivoluzionari – in quel Tale of Two Cities da cui abbiamo tratto l’esergo[56]).
Il radicalismo che aveva incendiato l’Europa resta in effetti una tentazione cui Mary Shelley si guarda assai bene dal cedere: per non cadere nell’unica forma di follia (da cui era chiaramente affetto il padre), che è quella che consiste nel perdere tutto fuorché la ragione (per dirla con Chesterton)[57].
Scorgiamo così agevolmente, in Frankenstein, dietro fonti d’ispirazione letteraria legate alla Rivoluzione, che evidenziano addirittura la medesima simbologia (un automa inventato da un certo … Frankenstein) [58], «un tiro alla fune tra due attitudini politiche in contrasto tra loro tenute [in] instabile equilibrio»[59].
In una tensione dialettica interiore al protagonista di cui l’ambientazione stessa costituisce piena rispondenza: essa infatti spazia dalla Ginevra di Calvino e Rousseau, in cui la religione scolora in religione civile, a scenari di desolazione in cui un’indomita natura riprende il sopravvento sull’uomo[60].
In mezzo, quella Ingolstadt, città natale della setta degli Illuminati, in cui l’unica religione rimasta è appunto la ragione scientifica: è infatti in questa città che Victor Frankenstein compie quegli studi universitari che pongono appunto le premesse della sua ‘caduta’[61].
In realtà, ciò che v’è di ‘sovversivo’ in Frankenstein non è un’adesione alle ideologie che avanzano, oppure a quelle che vanno formandosi in contrapposizione alle stesse, bensì, precisamente, il suo anti-razionalismo, il suo costituire, «in molti modi, la sovversione di ogni ideologia»[62].
Cosicché, se Mary Shelley appare consapevole che una rivoluzione politica, sociale, tecnoscientifica, economica è ormai in atto ed inarrestabile, e che nulla sarà dunque più come prima[63], a differenza dei genitori e del marito, forti del loro razionalismo ‘radicale’, non ha alcuna ‘ricetta’ da offrire[64].
Sembra infatti dire: siamo poi sicuri che i riformatori farebbero meglio? Non possiamo invero dimenticare che la famiglia di Felix (nomen omen?), i De Lacey, è una famiglia di attivisti politici in esilio, eppure risulta decisiva all’esclusione sociale della creatura (ma se ne può dire per ciò stesso ‘responsabile’?).
Forse, allora, data la condizione intermedia della ‘creatura’, la migliore pena è quella che essa infligge a se stessa, con il rimorso. Che è poi l’antica pena naturale: la pena che deriva dal sollevarsi della natura contro l’individuo per ciò di cui si è reso responsabile, attestandone la natura morale[65].
In fin dei conti, l’Ottocento è un secolo che, cominciato con il massimo interesse per il rigore della pena, finirà però, come si è visto, con quel positivismo penale che si propone invece di negarne alla radice il presupposto: il discorso sulla responsabilità: su ciò che rende, appunto, ‘criminali’.
4. Conclusivamente (ulteriori dubbi).
Di massima, si è tratti dall’opera d’arte a pensare non tanto, o non solo, a ciò che essa esprime di ‘attuale’ (qualunque cosa ciò significhi), quanto al modo in cui essa (ri)mette in forma la realtà, rivelandoci qualcosa anche su noi stessi e, nella prospettiva Law & Literature, sul diritto e le nostre istituzioni.
Quanto a Frankenstein, però, se di certo abbiamo tutti compreso che, per ragioni di prudenza, non è bene andarsene in giro a dissezionare cadaveri per assemblarne le parti e poi provare a resuscitare il tutto[66], per quel che attiene ai profili giuridici rilevabili non si va generalmente oltre gli aspetti ‘criminologici’, che sono poi quelli meglio filtrati nell’immaginario collettivo in due secoli di adattamenti e rivisitazioni, forse per meglio collocare l’opera entro il filone ‘gotico’ (ai cui canoni, per molti versi, si sottrae)[67]. Con più di qualche forzatura. Basti pensare alla ‘spiegazione’ della violenza della ‘creatura’ nella pellicola di Whale: essa sarebbe dovuta al fatto che, per una circostanza fortuita, era stata provvista del cervello di un ‘degenerato’(suggestione scopertamente lombrosiana, del tutto incompatibile con gli intenti filantropici del Frankenstein letterario).
Nell’analisi presentata si è invece inteso evidenziare la centralità della questione della giustizia penale, riletta – in chiaroscuro – come questione della labilità del confine tra ‘crimine’ e ‘morale’ nell’attribuzione di ‘responsabilità’: non è infatti ben dato dire, in Frankenstein, quali siano le condotte moralmente più gravi, né se alcune di esse possano comportare qualcosa sotto il profilo della sanzionabilità penale.
In particolare, poi, le implicazioni giuridico-morali delle condotte di Frankenstein e della ‘creatura’, poiché di queste principalmente si tratta, parrebbero avvalorare la tesi di una ambiguità costitutiva dell’opera, inducendo ad accedere ad una ulteriore chiave di lettura, che chiama in causa, ad integrazione dei riferimenti archetipici incontrati nel nostro incipit (Adamo e Prometeo), l’originaria dualità dell’uomo.
È questo, come si sarà senz’altro compreso, il tema del doppio[68], che si rivela qui alquanto sfuggente innanzitutto perché si traduce in un vero e proprio… doppio gioco da parte di Mary Shelley: come se vi fosse da discoprire un romanzo – il romanzo di una vita – nel romanzo (letterario).
Invero, si scorgono nitidamente, dietro le considerazioni che potrebbero attenere all’infelicità della condizione umana che ricorrono nella narrazione, situazioni di grave disagio che l’autrice patì in vita: certamente l’abbandono da parte della madre (alla sua morte), e quello da parte del marito (in un certo senso da vivo prima ancora che da morto), ma, più ancora, l’abbandono da parte del padre (quello che probabilmente le bruciava di più): vale a dire, il disinteresse da quegli dimostratole dopo esserne stata fino ai quattro anni la figlia prediletta (perciò non si capisce bene se in William Frankenstein, fratellino di Victor, Mary abbia in effetti inteso uccidere simbolicamente il padre, cui pure aveva dedicato l’opera – anche se poi, nella realtà, a morirle sarà l’omonimo figlio)[69].
In particolare, poi, accanto a questo sdoppiamento tra vita ed opera, invero connaturato alla creazione artistica, si determina uno sdoppiamento specifico operato da Mary Shelley nei vari personaggi di Frankenstein, specialmente con riferimento alla coppia attorno a cui ruota il plot[70]:
- Victor Frankenstein, che riflette l’indole fin troppo razionale dell’autrice (a lei trasmessa, e/o in lei rafforzata, dall’ambiente familiare, col suo radicalismo culturalmente elevato)[71],
- la ‘creatura’, la quale può considerarsi, al pari suo, vittima di egotismo e narcisismo da parte delle persone più vicine e – si direbbe – costituzionalmente outsider nella vita ‘reale’[72].
Parimenti, però, in un gioco di rimandi sul piano della finzione, (facendo la tara a Frankenstein quale io narrante) si potrebbe altresì ravvisare uno sdoppiamento della ‘creatura’ in alter ego del suo ‘creatore’, il quale, nel sostituirsi a Dio, avrebbe dato vita ad una ‘creatura’ a sua propria immagine e somiglianza (morale).
E, a saperli cogliere, parrebbero esservi vari indizi di questo. Per esempio:
- l’assenza di un vero e proprio nome imposto dal ‘creatore’ alla ‘creatura’;
- l’appellativo più frequente della ‘creatura’ è ‘demone’ (rinvio all’interiorità);
- l’indissolubilità del legame tra ‘creatore’ e ‘creatura’ (che lo raggiunge ovunque).
Letto in questa chiave[73], pur sull’onda di suggestioni letterarie all’epoca diffuse (è per esempio del 1814 Peter Schlemihl di Chamisso), Frankenstein parrebbe aver precorso almeno il William Wilson di Poe (1839) e Le Horla di Maupassant (1886), oltre che versioni del ‘doppio’ ad esso sicuramente ispirate come Great Expectations di Dickens (1860-1861) e Strange Case of Dr Jekyll andMr Hyde di Stevenson (1886)[74].
Se così fosse, l’opera di distruzione della vita di Victor Frankenstein che la ‘creatura’ presto intraprende, rientrerebbe a pieno titolo nella tematizzazione letteraria della zona d’ombra dell’essere umano, cui il doppio dà corpo, determinando uno strascico di dolore e pazzia che condurrà il protagonista alla morte[75].
Ma, andando più a fondo, si potrebbe anche dire che Frankenstein costituisce un’opera sull’inautenticità della vita, che è giocoforza sociale, e sul disgusto di sé che ne discende. Invero, vivere è rincorrere continuamente se stessi nell’altro, apprendendo, poco a poco, che non si potrà raggiungere nessuno[76].
Un po’ come suggerisce René Girard, la ‘creatura’ insegue Frankenstein, che costituisce il mediatore del suo desiderio (sociale), ma anche Frankenstein insegue la ‘creatura’, che parimenti costituisce – sia pur in negativo – il mediatore del suo desiderio (asociale) – per quanto lontano, indefinito, autodistruttivo[77].
Saremmo insomma condannati a vivere l’uno attraverso l’altro e dunque ad una condizione di infelicità dalla quale diritto e istituzioni non sarebbero certo in grado di riscattarci. Questa la conclusione che si potrebbe trarre da Frankenstein. Se non fosse che è stato scritto da una giovinetta nel fiore dell’età e delle speranze.* Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review.
** Il presente contributo costituisce risultato dell’attività di ricerca svolta nell’ambito del Progetto di Eccellenza 2018-2022 del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona (Diritto, Cambiamenti e Tecnologie - Laboratotio Jus-Fi).
[1] A Tale of Two Cities (1859), London 2003, p.5.
[2] M. Shelley, Frankenstein: or, The Modern Prometheus. L’edizione italiana presa a riferimento è: Frankenstein. Edizione originale del 1818, Vicenza 2018 (d’ora innanzi: F1818); l’edizione inglese presa a riferimento è: Frankenstein. The 1818 Text, J. P. Hunter (ed.), New York-London 1996 (d’ora innanzi: F1818-E).
[3] Tema che comprensibilmente si intreccia con quello della caduta, annunciato dall’esergo tratto dal Lost Paradise di John Milton. cfr. N. Gonzáles de la Llana Fernández, El pecado de Frankenstein, in Álabe, 7 (2013), http://revistaalabe.com/index/alabe/article/view/151. Sul carattere mitopoietico di Frankenstein, sulla sua ‘gestazione’ e sull’eredità che raccoglie, cfr. T. Alves, The Two Faces of a Myth: the Frankenstein Myth and its Mythological Heritage, in EM – Tese, 20.2 (2014), pp. 128-136, C. Baldick, In Frankenstein’s Shadow. Myth, Monstrosity and Nineteenth-Century Writing, Oxford 1987, J. J. Lecercle, Frankenstein. Mythe et philosophie (1998), trad. it., Frankenstein. Mito e filosofia, Napoli 2002, A. K. Mellor, The Modern Prometheus, in H. Bloom (ed.), Mary Shelley’s Frankenstein, New York 2007, pp. 78-85, L. A. Tudor, Frankenstein: the myth of dark creation, Romanian Journal of Artistic Creativity, 1.3 (2013), pp. 113-151. Ad alcune significative rivisitazioni moderne del mito di Prometeo, che in Mary Shelley – a differenza di quanto accade nel milieu romantico – assume tratti ambigui, è comunque dedicato M. P. Pattoni (a cura di), I volti di Prometeo. Storia, forme e fortuna di un mito Prometeo: gli ultimi fuochi, in Nuova Secondaria, 5 (2015).
[4] Cfr. M. Zanelli, Faber monstrorum: il mito di Prometeo come archetipo dell’horror, in M. P. Pattoni (a cura di), I volti di Prometeo. Storia, forme e fortuna di un mito Prometeo: gli ultimi fuochi, cit., pp. 57-78.
[5] È però la ‘creatura’ a comprendere infine che l’hybris della ‘creazione di Frankenstein può essere riequilibrata solo da una seconda ‘creazione’, intesa come atto d’amore (nei suoi confronti): v. M. Zanelli, Faber monstrorum: il mito di Prometeo come archetipo dell’horror, cit., p. 62. Sul ‘filo rosso’ che lega Adamo, Prometeo e lo scienziato moderno, cfr. G. Sermonti, La mela di Adamo e la mela di Newton, Milano 1974, cap.1.
[6] Proprio in quest’ordine, qualora si consideri la scienza nient’altro che razionalizzazione di procedure tecniche che gradualmente sarà condotta all’abbandono del primato del nesso tra tradizione ed esperienza. Cfr. G. Sermonti, L’anima scientifica. Simbolismo e funzione nella scienza, Chieti 1993.
[7] Per Emanuele Severino la tecnica mira all’incremento indefinito della capacità di realizzare scopi: il suo scopo è dunque trascendentale, a differenza delle altre forme di volontà di potenza, intese a realizzare scopi escludenti (norme religiose, morali, giuridiche, economiche, politiche). E la scienza finisce col costituire un tutt’uno con la tecnica, trovando la propria misura nel possibile (nel senso di: realizzabile), e rinunciando alla ricerca della verità assoluta. Cfr., a titolo esemplificativo, E. Severino, Il destino della tecnica, Milano 1998.
[8] Anziché a farli dimenticare. La figura di Frankenstein è dunque chiamata a fungere ‘mitologicamente’ da monito – ché ‘mostro’ contiene al suo interno monere: v. J. M. van der Laan, Frankenstein as Science Fiction and Fact, in Bulletin of Science, Technology & Society, 30.4 (2010), pp. 298-304, qui p. 303.
[9] Cfr. D. S. Hogsette, Metaphysical Intersections in Frankenstein: Mary Shelley’s Theistic Investigation of Scientific Materialism and Transgressive Autonomy, Christianity and Literature, 60.4 (2011), pp. 531-559.
[10] Invero, l’idea dello scienziato – per non dire del termine stesso – sembra sconosciuta fino a Frankenstein, e forse buona parte del carattere ‘mitologico’ del personaggio eponimo risiede proprio nel fatto che troviamo rifusi nella sua persona il fantastico e il magico (non si dimentichi che egli perverrà all’esperimento attraverso studi di filosofia naturale).
[11] Fonte principale di Mary Shelley fu verosimilmente un’opera del padre, per vero piuttosto schematica: cfr. W. Godwin, The Pantheon: or Ancient History of the Gods of Greece and Rome, London 1814, 4a ed., cap.10.
[12] Che va ben oltre la tematica ‘esplicita’ dei trapianti d’organo. Cfr. A. R. Jonsen, Frankenstein and the birth of medical ethics, in H. Colt – S. Quadrelli – L. Friedman (eds.), The Picture of Health. Medical Ethics and the Movies, New York 2011, pp. 3-10 e W. Cude, Mary Shelley’s Modern Prometheus: A Study in the Ethics of Scientific Creativity, in Dalhousie Review, 52 (1972), pp. 212-225.
[13] Cfr. P. Fara, Realtà o finzione? Mary Shelley, la scienza e Frankenstein, DEP, 35.11 (2017), pp. 5-25.
[14] Cfr. J. E. Hogle, The Gothic Image at the Villa Diodati, «Wordsworth Circle», 48.1 (2017), pp. 16-26 e B. R. Pollin, Philosophical and Literary Sources of Frankenstein, «Comparative Literature», 17 .2 (1965), pp. 97-108.
[15] Cfr., e.g., K. Ellis, Monsters in the Garden: Mary Shelley and the Bourgeois Family, in G. Levine – U. C. Knoepflmacher (eds.), The Endurance of Frankenstein. Essays on Mary Shelley’s Novel, Berkeley-Los Angeles-London 1979, pp. 123-142.
[16] Discorso assai complesso: cfr. ad es. A. K. Mellor, Possessing Nature: the Female in Frankenstein, in Ead. (ed.), Romanticism and Feminism, Bloomington 1988, pp. 220-232e N.Yousef, The Monster in a Dark Room: Frankenstein, Feminism and Philosophy, in MLQ: Modern Language Quarterly. 63.2 (2002), pp. 197–226.
[17] Cfr. G. N. Berti, William Godwin – Giustizia politica e felicità, in Id., Un’idea esagerata di libertà. Introduzione al pensiero anarchico, Milano 2015, pp. 27-48 e J. McGeough, ‘So Variable and Inconstant a System’: Rereading the Anarchism of William Godwin’s Political Justice, in Studies in Romanticism, 52.2 (2013), pp. 275-309. Con specifico riferimento alla riflessione critica sul fenomeno penale (particolarmente rilevante nella presente sede), cfr. invece P. Marconi, La libertà selvaggia. Stato e punizione nel pensiero anarchico, Venezia 1979, pp. 94-98.
[18] Cfr. C. Franklin, Mary Wollstonecraft. A Literary Life, New York 2004 e N. Fuehrer Taylor, The Rights of Woman as Chimera. The Political Philosophy of Mary Wollstonecraft, New York-London 2007; per un inquadramento generale cfr. invece D. Weiss, The Female Philosopher and Her Afterlives. Mary Wollstonecraft, the British Novel, and the Transformations of Feminism, 1796-1811, New York 2017.
[19] Lo testimoniano inequivocabilmente, tra le altre cose, oltre a Queen Mab (1813), il poema filosofico per cui Percy Bysshe Shelley era divenuto famoso all’epoca in cui conobbe Mary, The Masque of Anarchy (1819) e il dramma Prometheus Unbound (1820). Cfr. comunque M. H. Scrivener, Radical Shelley: The Philosophical Anarchism and Utopian Thought of Percy Bysshe Shelley, Princeton (N. J.) 1982.
[20] Cfr. G. Bakay, William Godwin, Mary Wollstonecraft, Mary Shelley, and Their Offspring, Victor Frankenstein. A Family of Rebels, Lewiston (NY)-Lampeter (Wales) 2016, spec. cap. 4.
[21] J. A. Carlson, England’s First Family of Writers. Mary Wollstonecraft, William Godwin, Mary Shelley, Baltimore (MD) 2007.
[22] La prima edizione, del 1818, uscì anonima (benché dedicata al padre), in sole 500 copie, e vide un consistente apporto del marito Percy. Le due successive edizioni, del 1823 e del 1831, paiono però averne mutato la ‘torsione’ (forse snaturandone l’ispirazione). Per approfondimenti cfr. C. E. Robinson, Frankenstein. Its Composition and Publication, in A. Smith (ed.), The Cambridge Companion to Frankenstein, Cambridge 2016, pp.13-25. Sul viaggio in Italia cfr. ad es. F. Sampson, In Search of Mary Shelley. The Girl Who Wrote Frankenstein (2018), trad. It., La ragazza che scrisse Frankenstein. Vita di Mary Shelley, Torino 2018, cap. 8.
[23] Per via di una complessa serie di circostanze: cfr. W. St Clair, The Impact of Frankenstein, in B. T. Bennett – S. Curran (eds.), Mary Shelley in Her Times, Baltimore (MD)-London 2000, pp. 38-56.
[24] Chi ricorda, ad esempio, che Victor Frankenstein è partenopeo di nascita (e solo ginevrino di adozione)? Si tratta però di un’integrazione introdotta con la 3a ed.: Frankenstein, vol. I, London 1831, p. 20.
[25] B. Croce, Filosofia della pratica. Economica ed Etica, Bari 1923, 3a ed., pp. 358-359.
[26] L’ambiguità che si esprime nel male del crimine ha a che fare con la duplicità connaturata alla condizione umana e ben effigiata dallo sdoppiarsi di Victor Frankenstein nella sua ‘creatura’: v. A. K. Mellor, Making a ‘monster’: an introduction to Frankenstein, in E. Schor (ed.), The Cambridge Companion to Mary Shelley, Cambridge 2003, pp. 9-25, qui p. 23. Vi torneremo in chiusa (§ 4.).
[27] F1818, p. 100 (F1818-E, p.34). Frankenstein offre una descrizione della ‘creatura’, che procede per accumulo di particolari sinistri, che poi confluiscono in un giudizio finale «colmo di un orrore e un disgusto che [tolgono] il fiato». Cfr. anche D. Gigante, Facing the Ugly: The Case of ‘Frankenstein’, in ELH, 2 (2000), pp. 565-587.
[28] O comunque non tali da destare in lui particolare preoccupazione per l’aspetto: v. F1818, p.102 (F1818-E, p. 35).
[29] Immagine che costituisce a tutt’oggi l’opera più nota di Theodor Holst: v. S. Poë, Theodor von Hoist; His Art and the Pre-Raphaelites – Exhibition Review, in The British Art Journal, 11.2 (2010-2011), pp. 100-101, qui p. 100.
[30] Così J. A. W. Heffernan, Looking at the Monster: ‘Frankenstein’ and Film, in Critical Inquiry, 24.1 (1997), pp. 133-158, qui p. 147: «i volti che originariamente gli artisti della Universal schizzarono per la creatura nel Frankenstein di Whale risultavano per la maggior parte decisamente atavistici, giusto il tipo di volto che Lombroso pensava intrinsecamente criminale» (questi primi studi si trovano riprodotti in D. J. Skal, The Monster Show. A Cultural History of Horror, New York 1993, p.133).
[31] Vedasi C. Lombroso, L’Uomo delinquente studiato in rapporto alla antropologia, alla medicina legale ed alle discipline carcerarie, 1a ed., Milano 1876, pp. 2, 202 e passim. Si tratta di un filone di studi che, per quanto possa apparire eccentrico ed ormai superato dalla storia, sta rivelando proprio ai giorni nostri una non comune vitalità: cfr. P. Knepper – P. J. Ystehede (eds.), The Cesare Lombroso Handbook, London-New York 2013, E. Musumeci, Cesare Lombroso e le neuroscienze: un parricidio mancato. Devianza, libero arbitrio, imputabilità tra antiche chimere ed inediti scenari, Milano 2012, A. Raine, The Anatomy of Violence. The Biological Roots of Violence (2013), trad. it., L’anatomia della violenza. Le radici biologiche del crimine, Milano 2016, D. Velo Dalbrenta, La scienza inquieta. Saggio sull’Antropologia criminale di Cesare Lombroso, Padova 2004.
[32]Cfr. G. Antonini, I Precursori di C. Lombroso, Torino 1900, cap. 5. Sul piano biografico va poi ricordato che Lavater fu amico di Füssli (quel Füssli), precedente fidanzato della madre di Mary, che il suo primo traduttore inglese – Thomas Holcroft – era amico di Godwin, ma anche che, proprio su richiesta del padre, Mary stessa fu sottoposta – quando aveva appena tre settimane di vita! – ad esame fisiognomico da parte di un suo seguace: la lettera – datata 18 settembre 1797 – in cui questo vicino di casa seguace di Lavater, tal Mr Nicholson, relaziona circa il suddetto ‘esame’ (dagli esiti lusinghieri), è contenuta in R. Glynn Grylls, Mary Shelley. A Biography, London-New York-Toronto 1938, pp. 10-11. Quanto alle tracce che conducono a Füssli, è stata anche notata, in Frankenstein, una certa ispirazione alla sua opera, e in particolare la somiglianza tra L’Incubo e la scena in cui Victor Frankenstein rinviene il corpo ormai esanime della moglie, riverso sul talamo (F1818, p. 267; F1818-E, p. 135): cfr. M. C. Ward, Painting of the Unspeakable: Henry Fuseli’s The Nightmare and the Creation of Mary Shelley’s Frankenstein, in The Journal of the Midwest Modern Language Association, 33.1 (2000), pp. 20-31.
[33] Per un quadro generale delle conoscenze scientifiche dell’epoca plausibilmente ‘contenute’ in Frankenstein cfr. K. Harkup, Making the Monster. The Science Behind Mary Shelley’s Frankenstein, London 2018.
[34] Cfr., per approfondimenti, G. Antonini, I Precursori di C. Lombroso, cit., capp.2-4.
[35] F1818, p. 295; F1818-E, p. 153. Ricordo che Walton si fa ora protagonista della narrazione da narratore che era.
[36] Per questa notissima distinzione cfr. H. L. A. Hart, Postscript: Responsibility and Retribution (1968), trad. it. in Responsabilità e pena. Saggi di filosofia del diritto, Milano 1981, pp. 240-251.
[37] Come si ricorderà, l’aveva laicamente affermato – appena qualche anno prima – il matematico, fisico ed astronomo francese P. S. Laplace: v. Essai philosophique sur les probabilités (1814), trad. it., Saggio Filosofico sulle probabilità, in Opere, O. Pesenti Cambursano (a cura di), Torino 1967, pp. 233-404, qui p. 243. Non senza aggiungere, peraltro, che lo spirito umano resterà sempre lontano da tale intelligenza, cui potrà solo tendere all’infinito (ibi, pp. 243-244).
[38] Per un’agile disamina dei profili di responsabilità districabili in Frankenstein cfr. comunque J. Johnston, Traumatic Responsibility. Victor Frankenstein As Creator And Casualty, in M. Shelley, Frankenstein: or, The Modern Prometheus – Annotated for Scientists, Engineers, and Creators of All Kinds, D. H. Guston – E. Finn – J. S. Robert (eds.), Cambridge (MA)-London 2017, pp. 201-207.
[39] Ci si riferisce alle morti di William, Clerval, Elizabeth (di fatto uccisi dalla ‘creatura’), cui vanno poi indirettamente ricondotte l’esecuzione di Justine, nonchè le morti naturali del padre di Frankenstein e di Frankenstein stesso.
[40] Nonostante noti antecedenti (come Vico), la nota tesi – fondamentalmente antropologica – dell’inintenzionalità delle conseguenze dell’agire umano (intenzionale), perlomeno riguardato nelle terminazioni ultime, è stata discussa ed approfondita soprattutto dalle scienze sociali, e, di qui, soprattutto nel contesto del pensiero liberale, come si può ben vedere in K. R. Popper, Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge (1969), trad. it., Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Bologna 1972, p. 580. Per un giro d’orizzonte si rinvia a L. Infantino, L’ordine senza piano. Le ragioni dell’individualismo metodologico, Roma 2008.
[41] F1818, p. 297 (corsivi aggiunti); F1818-E, pp. 154-155.
[42] Per un bilancio di tale esperienza, per molti versi costitutiva di ciò che (anc)ora chiamiamo ‘sistema penale’, cfr. P. Pittaro (a cura di), Scuola Positiva e sistema penale: quale eredità?, Trieste 2012.
[43] F1818, pp. 295-296; F1818-E, p. 153.
[44] C. Lombroso, Troppo presto. Appunti sul nuovo codice penale, Torino 1888, p. 23: «[I]l diritto [di punire] ci viene dalla necessità della difesa […]. [L]a pena […] è